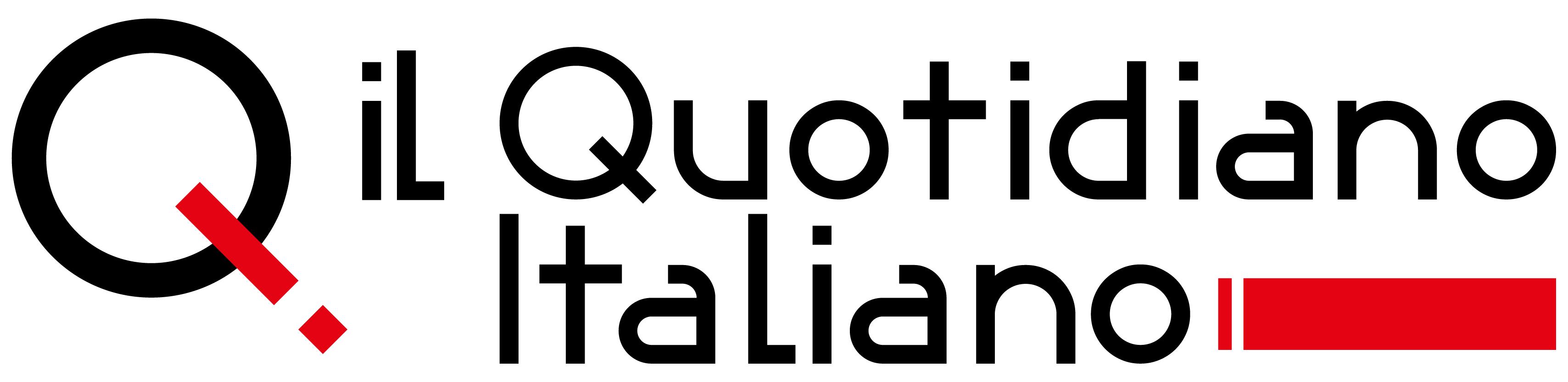“Mi picchia, ci sono giorni in cui si ammazza di alcol, mi sento la sua crocerossina e penso di poterlo salvare, come se l’amore potesse fare miracoli”; “Mi pesta di santa ragione, ma io lo amo. Copro i lividi con il fondotinta e vado a lavoro”; “Mio marito beve e poi mi violenta, i miei suoceri dicono che si ubriaca perché non sono in grado di dargli un figlio”. Sembrano frasi di uno stesso macabro film, l’introduzione di una di quelle storie simulate che riempiono i programmi crime in onda a notte fonda. Invece no, sono i flussi di dolore e coscienza che abitano il corpo e la mente di Carla, Sara e Giovanna. Tre donne reali con storie di violenza intrise di terrore e senso di colpa, accomunate dall’incontro di uomini piccoli, esseri infimi incapaci di amare, accecati dal possesso, dal sopruso, dalla più marcia virilità. Tre madri che hanno trovato la forza di denunciare guardando negli occhi i loro figli, aggrappandosi a loro, diventati l’unico motivo per sopravvivere agli abusi.
Le donne che abbiamo ascoltato sono assistite dall’Associazione Vittime di Violenza – IO NO, fondata da Marina Brasiello, presidente della stessa, affiancata da molti avvocati sul territorio nazionale, primi tra tutti Alberto Marsili Feliciangeli e Alessio Tanzi, entrambi presenti nel corso dei nostri colloqui con Carla, Sara e Giovanna. Quest’associazione senza scopo di lucro lotta da 14 anni al fianco di chi è offeso, maltrattato, abusato e perseguitato, supportando con cura anche le loro famiglie. Ciò che c’è di falso nelle tre lunghe storie che vi proponiamo sono solo i nomi dei protagonisti, perché le donne incontrate brancolano ancora nel terrore, sentono scricchiolare i passi dei loro mostri pur essendo ormai fuori dalla morsa, e noi preferiamo proteggerle. Che le loro testimonianze restino in circolo ben oltre il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, facendosi largo nella nostra memoria a lungo termine di esseri umani e cittadini.
La storia di Carla
«Mi chiamo Carla, arrivo in Italia il 24 maggio 2002, a 29 anni. Inizio a lavorare in un albergo e dopo due mesi conosco Stefano, un uomo interessante che viene sempre lì a soggiornare. Mi innamoro perdutamente di lui, è dolcissimo, mi riempie di attenzioni. Mi racconta di come sia stato vittima di una storia andata male e io gli confido di essere cresciuta in una famiglia patriarcale, figlia di un padre aggressivo, nata e vissuta, forse anche concepita, nella violenza. Sento di aver trovato qualcuno con le spalle larghe, pronto a reggere con amore la mia costellazione di fragilità. Dopo un paio di mesi cominciano le scenate di gelosia, Stefano diventa morboso, non vuole che esca, mi sente come una sua proprietà, ma ho un bagaglio di umiliazioni così ricco che forse non sono nemmeno scioccata dal fatto che abbia incontrato un compagno simile a mio padre».
«Passano gli anni, i lividi e le botte non trovano più spazio sulla mia pelle, fino a che non divento madre. Nasce Michele e tutto cambia, si innesca in me un meccanismo diverso, sono disposta a qualunque cosa pur di salvare il mio bambino. La gente mi dice che Stefano ha maltrattato in passato i genitori, le sorelle, i fratelli, l’ex moglie e i figli di quel primo matrimonio. Penso di aver fatto un figlio con un mostro; lo metto alle strette, gli dico cosa ho scoperto sul suo conto, lui nega, giurando di non aver mai abusato di nessuno».
«Una sera Stefano è in preda ai fumi dell’alcol, solleva Michele e inizia a giocarci, il piccolo cade e sbatte la testa sul tavolo. Forse è stato un incidente, non voleva farlo. Ho talmente tanta paura quando beve che non riesco a impedirgli di prendere in braccio nostro figlio, resto paralizzata. Un’altra volta trovo dell’erba in casa, gli chiedo spiegazioni, mi dice che non è sua, ma di un suo amico. Allora la butto nel wc, c’è il bimbo e non voglio se la ritrovi per le mani. Stefano se ne accorge e mi picchia selvaggiamente. Non riuscirò mai a cancellare dalla mia mente il ricordo di un altro episodio orrendo: Michele ha 4 mesi, lo sto allattando e il mio compagno vuole penetrarmi proprio in quel momento. Gli dico di aspettare, il tempo di mettere il bimbo nella culla e lo avrei lasciato fare. Ma niente, non ascolta ragioni: “Brutta tr… bastarda, pensi a lui e non a me”».
«Nel 2007 non ce la faccio più, decido di lasciarlo. Mi trasferisco a casa di mia sorella, porto con me Michele. Ma dopo 4 mesi comincio a sentirmi un peso, lei si è separata da poco ed è una situazione difficile. Intanto Stefano mi scongiura di tornare, promette che avrebbe smesso di bere, che sarebbe cambiato, che avrei dovuto pensare al bene del bambino, non potevo privarlo di un padre. Faccio le valigie e rientro a casa. La storia non cambia, peggiora. Dopo 6 anni di convivenza nel 2008 capisco che non c’è più nulla da salvare, se non me e Michele, così scelgo di denunciare Stefano per maltrattamenti in famiglia. Vado in pronto soccorso per farmi refertare le ferite che mi ha procurato e mi danno 15 giorni di prognosi. Quel giorno mi reco anche dai Carabinieri, ma non c’è nessuno che possa verbalizzare la mia denuncia, mi chiameranno loro quando ci sarà qualcuno pronto a mettere nero su bianco le violenze subite. Ho paura, ho bisogno di andare via da quella casa, vado a stare da mia sorella per un po’, ma non troppo perché lui potrebbe venire a cercarci».
«Arriva il 25 novembre 2008 e finalmente vengo chiamata in caserma per denunciare. Da quel momento nella mia vita inizia a riaccendersi la luce. Cerco un lavoro e richiedo in Tribunale il gratuito patrocinio per avere un avvocato che mi difenda durante il processo. Dopo ben 5 anni di processo, tra rinvii, verbali spariti nel nulla e udienze fantasma, arriva il giorno in cui vengo chiamata a testimoniare dinanzi al giudice. Il magistrato è una donna e mentre parlo mi dice di stringere, che non devo perdermi nei dettagli. Com’è possibile che ho aspettato tutti questi anni per vomitare al mondo cosa mi ha fatto quell’uomo, parlare del trauma che mi ha inferto, e mi ritrovo dinanzi a qualcuno che preferisce invece non conoscere i particolari? Mi sento umiliata».
«Nel 2014, a 6 anni dalla denuncia, Stefano viene condannato a 6 mesi di reclusione e una provvisionale di 5mila euro per violenza privata e lesioni personali, assolto, invece, per il reato di maltrattamenti in famiglia in quanto il fatto non sussiste. Questo perché i giudici pensano che una sola denuncia non dimostri nulla, oltre al fatto che secondo loro avrei dovuto recarmi dai Carabinieri molto prima. Il legale del mio aguzzino fa ricorso e dopo altri 4 anni andiamo in Corte d’Assise dove assisto all’ennesima barzelletta: mi sento dire che i reati sono stati prescritti e l’imputato prosciolto. Stefano se l’è scampata grazie alla burocrazia, ai ritardi della Giustizia, al fatto che per anni qualcuno si è praticamente dimenticato il fascicolo delle mie torture. Ora lui è morto, ma io continuo a fare gli incubi, ad andare in apnea ogni notte. Ma sono caparbia, amo troppo la vita e ho combattuto contro tutti e tutto per tornare a star bene, per smetterla di colpevolizzarmi».
«Michele ha 18 anni, e, nonostante abbia capito che siamo noi le vittime di questa vicenda, mi reputa responsabile della sua infelicità, dice che sono stata io a scegliere per lui quel padre. La mia paura più grande è che mio figlio possa diventare un giorno come Stefano, così come c’è il rischio che una figlia che ha visto e subito maltrattamenti cresca con l’idea che quella sia una situazione normale e caschi nella trappola di uomini violenti, ciò che è successo a me. Mio figlio non ha fatto terapia cognitivo-comportamentale quando era piccolo perché non potevo permettermelo, una seduta costava 90 euro e ne avrebbe dovute fare almeno due a settimana. Per quanto abbia cercato di crescerlo al meglio, raccontandogli quanto male mi ha fatto suo padre, lui non ha avuto un aiuto psicologico ed è ciò che invece dovrebbe garantire lo Stato alle vittime e i loro familiari».
La storia di Sara
«Mi chiamo Sara, è il 2003 e ho 30 anni. Incontro per caso Giacomo sul treno, è seduto affianco a me. Mi innamoro di lui, ma dopo i primi mesi della nostra storia mi rendo conto che alza troppo il gomito. Quando beve si trasforma e sfoga la sua rabbia su di me. Non faccio in tempo a rendermi conto di chi sia davvero che resto subito incinta della nostra prima figlia. Giada nasce nel luglio 2004 e a settembre ci sposiamo. L’incubo vero inizia dopo il secondo genito, Mirco. Giacomo è violento, ha sempre una scusa per non andare a lavoro e passa intere giornate davanti ai videopoker. Si gioca tutti i soldi del mio stipendio, fregandosene di lasciarci senza cibo. Nel frattempo mio padre si ammala di tumore e mi crolla il mondo addosso. Decido di stare vicino ai miei genitori, da quel momento lui tutte le mattine dà in escandescenza e vengo a sapere che mi tradisce».
«Sono uno straccio. Una volta mentre siamo in giro con Mirco, litighiamo e mi scaraventa addosso il passeggino con il piccolo dentro, sotto lo sguardo della gente. Purtroppo è così, quando perde il controllo tutto quello che ha a portata di mano lo lancia contro di me. Un collega mi consiglia di rivolgermi al telefono rosa, ma non mi aiutano molto, perché supero l’Isee e non rientro tra le donne che possono essere assistite gratuitamente. La legge sul codice rosso arriva solo nel 2019, nel periodo in cui io subisco violenze devi cercare di salvarti da sola».
«Nel 2012 decido di lasciare Giacomo, vado a casa dei miei genitori in un altro paese e porto via i bambini. In quell’occasione, dopo un’infinità di mie segnalazioni alle Forze dell’Ordine, i Carabinieri fanno partire una denuncia per stalking e violenza domestica. Lui va via, ma non smette di torturarmi, non rispetta la misura di allontanamento di 200 metri. Un giorno torna tra le mura domestiche, approfittando del fatto che sono a lavoro, e minaccia Mirco, gli dice: “Guarda come ti butto la mammina giù dal quinto piano quando torna“. La babysitter è lì, ascolta tutto. I vicini sentono i pianti del bimbo, così chiamano i militari e scatta l’ennesima denuncia nei suoi confronti. Qualche tempo dopo io e i miei figli siamo seduti al bar in piazza: lui ci vede, vìola ancora l’ordine restrittivo, impazzisce e mi pesta pubblicamente. Mi danno 5 giorni di prognosi per quell’episodio e purtroppo ce ne vorrebbero 7 per sbatterlo in carcere».
«Dal 2013 riesco ad avere l’affido esclusivo dei miei bambini, ma lui continua a perseguitarmi. Mi chiama con insistenza, mi investe di insulti e poi puntualmente dopo 10 minuti si scusa. Si sono aperti 3 processi a suo carico, per uno è stato condannato a 7 anni e 10 mesi per violenza domestica. Sono ben 9 anni che aspettiamo venga avviato il secondo grado per gli altri procedimenti e mi sembra che il vento soffi dalla sua parte, visti i tempi biblici della Giustizia. Lui sente ovviamente i ragazzi, sono i suoi figli, è giusto. L’altra volta ha chiamato Giada per dirle che la sua nuova compagna è molto più bella di me, se questa non è violenza psicologica…»
«Mirco oggi ha 13 anni, è iperprotettivo nei miei confronti, praticamente il mio bodyguard. Il ragazzo non riesce a restare da solo in casa, se mi allontano mi chiama dopo pochi secondi. Giada ha disturbi del comportamento alimentare; prima cercava suo padre, ora ha smesso di farlo. Oggi mi sento più forte, ho raggiunto una consapevolezza tale che sono ormai in grado di mandare beatamente a quel paese il mio ex, ma è un percorso di dolore che non ha fine. Vivo nell’ansia che possa tornare e farci del male. I miei figli hanno paura per me, fin da piccoli si sono messi in mezzo quando il loro padre mi picchiava, cercando di fermarlo. Mirco non dimenticherà mai quella volta in cui eravamo vicino all’ascensore e Giacomo mi ha menata davanti ai suoi occhi, sferrandomi calci al femore; mio figlio sussurra ancora che avrebbe voluto essere colpito lui quel giorno al posto mio. Il giovane ha una sensibilità eccessiva e temo che possa essere influenzato da cattive compagnie o possa diventare vittima di bullismo. Il peso delle violenze non ci abbandona, ed è una cosa che non si supera mai».
La storia di Giovanna
«Mi chiamo Giovanna, siamo negli anni ’90 e ho 22 anni. Una sera, alla festa patronale del mio paese, incontro Roberto, colui che sarebbe diventato mio marito, iniziamo a chiacchierare. Ho già sentito parlare di lui, so che studia fuori. Verso la fine della serata mi accorgo che puzza di alcol, non do peso alla cosa, d’altronde siamo tutti un po’ brilli. Nel periodo successivo ci perdiamo di vista, vado anch’io all’università e frequento poco le mie zone. Io e Roberto ci ritroviamo grazie a degli amici comuni che ci mettono in contatto, così iniziamo a conoscerci. All’apparenza è un tipo tranquillo, molto logorroico, soprattutto se ha bevuto un bicchiere di troppo. Insomma, siamo innamorati e ci fidanziamo. Faccio notare a Roberto, però, che non mi piace vederlo bere, né come si comparta dopo averlo fatto, lui mi promette che è solo un modo per passare del tempo con gli amici. Ne parlo anche con i suoi genitori, mi dicono di stare tranquilla, è un ragazzo a posto».
«La storia va avanti tra alti e bassi. Quando lui è ubriaco alza la voce, poi dopo un attimo si scusa e comincia a piangere; inizio a capire che Roberto ha una personalità instabile. Nel frattempo ci sposiamo, la sera del matrimonio è completamente marcio. Passano i giorni, gli anni e lui non si sbronza più solo con gli amici, ma lo fa in ogni momento della giornata. Roberto non si laurea, inizia a lavorare, aumentano le sue frustrazioni; si rivela un uomo debole che non sa dire di no alla sua famiglia d’origine abituata alla violenza. I genitori invece di aiutarlo in un percorso di disintossicazione, gli ripetono quanto sia un fallito. Il padre è un uomo aggressivo, anche lui beve e Roberto è cresciuto seguendo il suo esempio, non è mai riuscito a ribellarsi a quei soprusi. Scopro che mio marito è un uomo piccolo e fragile che ha represso per tutta la vita dei traumi e, forse, per questo alza la voce con me».
«I primi anni di matrimonio prova a fare dei percorsi di disintossicazione, ma senza grandi risultati. I genitori di Roberto dicono che la colpa è mia se beve, perché non sono in grado di dargli un figlio, non sono una brava moglie. Mi sento doppiamente violentata, tra le mura di casa e fuori. Finalmente dopo 7 anni arriva un bambino, Giosuè. Lui sta ancora peggio, dice che non gli do più attenzioni, si sente trascurato e ci beve su. La madre e la sorella mi rimproverano per non aver dato il nome del nonno a nostro figlio e sgridano Roberto perché non sa farsi rispettare. Insomma, non sono brava come moglie, né come mamma. Inizio quasi a convincermi che sia vero, che non sia sufficientemente buona come donna. Più mi accusano e più credo che quelle accuse nei miei confronti siano reali. In quel periodo lui inizia a spintonarmi, a gridare contro di me, insultare senza motivo la mia famiglia. Mia madre e mio padre vengono spesso a trovarmi e sono puntualmente cacciati da Roberto, presi di peso e buttati fuori casa».
«Tra il 2018 e il 2019 lui tocca il fondo, non va più a lavoro, se ci va è sempre sbronzo. Molte volte non si regge in piedi in ufficio e i suoi colleghi lo cambiano in bagno per far in modo che i superiori non se ne accorgano. Passa quasi tutta la sua vita a casa, dorme fino alle 17, la notte si attacca alla bottiglia, spesso si addormenta a tavola fradicio. Io cerco sempre delle vie di fuga, quando posso vado a trovare i miei, porto il bambino in giro in auto tutto il giorno, per tenerlo lontano da lui. Poi quando Roberto non ha soldi va in crisi di astinenza e spacca l’auto per trovare anche pochi centesimi. È paranoico, mi accusa di avere un’altra storia e mi definisce nel peggiore dei modi vicino a mio figlio. Mi mette le mani addosso, dice di dover sfogare i suoi istinti e mi violenta. Provo tanta vergogna, mi sento sporca, nonostante sia io quella che lo ripulisce dal vomito».
«Roberto entra nell’ultimo percorso di recupero, ha una depressione acuta e un’encefalopatia epatica causata dal vino, anche un disturbo dell’umore, praticamente vivo con un pazzo. Un mio amico mi consiglia di rivolgermi a un centro antiviolenza e io provo a chiamare. Loro mi dicono che il prossimo passo da fare è chiamare le Forze dell’Ordine, ma ho paura che nessuno mi creda e temporeggio. Fino a che a metà novembre 2019 torno a casa e trovo Roberto in crisi d’astinenza che mi chiede di portarlo in stazione per andare a lavoro. Lo accompagno, ma verso le 10 mi chiama un suo collega per dirmi che sta rientrando; Roberto ha chiesto soldi a tutti in ufficio, ma nessuno glieli ha dati».
«Rientro verso le 17 e mio marito dorme, so per certo che è arrabbiato per non aver trovato nessuno che gli abbia concesso un prestito. Appoggio le chiavi e mi cambio. Sento il passo di Roberto in mezzo alle scale, sta scendendo dal piano di sopra. Allora mi affaccio e dico: “Stai male? Se stai male andiamo in pronto soccorso, facciamo un ricovero”. È una furia, si scaraventa contro di me, mi stringe le mani al collo davanti a mio figlio, mi prende la testa e la sbatte contro la porta: “Ricordati che ti ammazzo“. Il bimbo inizia a urlare: “Basta, lascia la mia mamma!”. Giosuè si avventa contro il papà e lui allora molla la presa: sono salva, mio figlio di 5 anni mi ha salvato. Scappo, prendo il piccolo e le chiavi di casa e decido di andare dai Carabinieri. Ma in auto tremo, sto male, il bambino è in preda a una crisi di pianto, così mi fermo al pronto soccorso».
«Le infermiere chiedono a Giosuè in lacrime cosa sia successo e lui svuota il sacco: “Papà ha stretto la gola a mamma, papà fa male a mamma“. Quel giorno in ospedale mi chiedono perché non voglia denunciare mio marito e mi informano che la testimonianza del bambino è schiacciante, motivo per cui chiamano i Carabinieri. Questi ultimi mi chiedono se confermo ciò che ha riferito mio figlio, sottoscrivo tutto e parte la denuncia. Il giorno dopo rientro a casa con i militari per prendere l’essenziale e andare via, lui ci guarda e blatera: “Sono pentito solo di una cosa, ieri sera avrei dovuto ammazzarti“. Ovviamente le sue frasi vengono messe a verbale. Mi trasferisco lontano da quell’inferno e lui continua a tempestarmi di messaggi dicendo che mi ama e che è stato solo un modo per intimorirmi. Il mio avvocato e il centro antiviolenza mi dicono di tranquillizzarlo, di fargli sentire il bambino almeno fino al processo, nonostante il suo obiettivo non sia arrivare a Giosuè, ma a me. Verso fine anno lui, non potendo più avvicinarsi a noi, inizia a farmi violenza tramite social, pubblicando ingiurie e bugie sul mio conto e sulla mia famiglia».
«Roberto viene processato e condannato a un anno e 8 mesi con rito abbreviato per violenza domestica. L’avvocato lo fa entrare in un percorso di disintossicazione e dopo soli due mesi esce dalla comunità, più arrabbiato di prima, senza scontare la pena. Dopodiché Roberto vìola due volte la misura cautelare del divieto d’avvicinamento, affitta un appartamento difronte al mio ufficio, mi osserva tutti i giorni e pubblica su Facebook i miei movimenti e quelli di Giosuè, fino a quando a ottobre 2021 non scatta per lui anche il braccialetto elettronico. La cosa più assurda è che in quel periodo propongono a me e mio figlio di entrare in una casa di accoglienza per vittime di violenza, come se fossimo noi gli elementi pericolosi da isolare; mi rifiuto categoricamente e resto a casa mia».
«Nonostante le misure restrittive lui continua a chiamarmi a tutte le ore, si presenta dove lavoro, lasciandomi fiori e foto. Poi al danno la beffa, i suoi parenti chiedono che a me e al bambino venga fatta una perizia psichiatrica, come se i pazzi pericolosi fossimo noi. Mi accusano ancora una volta del fatto che io non sia una mamma idonea e che Roberto abbia iniziato a bere perché non gli permettevo di vedere il bambino. Vengo violentata nell’animo da lui e dalla sua famiglia. Un anno fa purtroppo Roberto è morto, dico purtroppo perché ancora adesso sento di dovermi liberare di questa figura che è stata presente nella mia esistenza per 25 anni. Penso che mi abbia lasciato degli strascichi incredibili dentro, continuo ad aver paura nonostante non sia più in questo mondo. Giosuè oggi ha 8 anni, ha disturbi del linguaggio ed è seguito da alcuni psicologi e logopedisti; dice di odiare il padre perché mi ha fatto troppo male. Mio figlio credo non ricordi molto di Roberto, ma racconta a tutti quando lo ha visto strangolarmi, quella scena non l’ha cancellata».