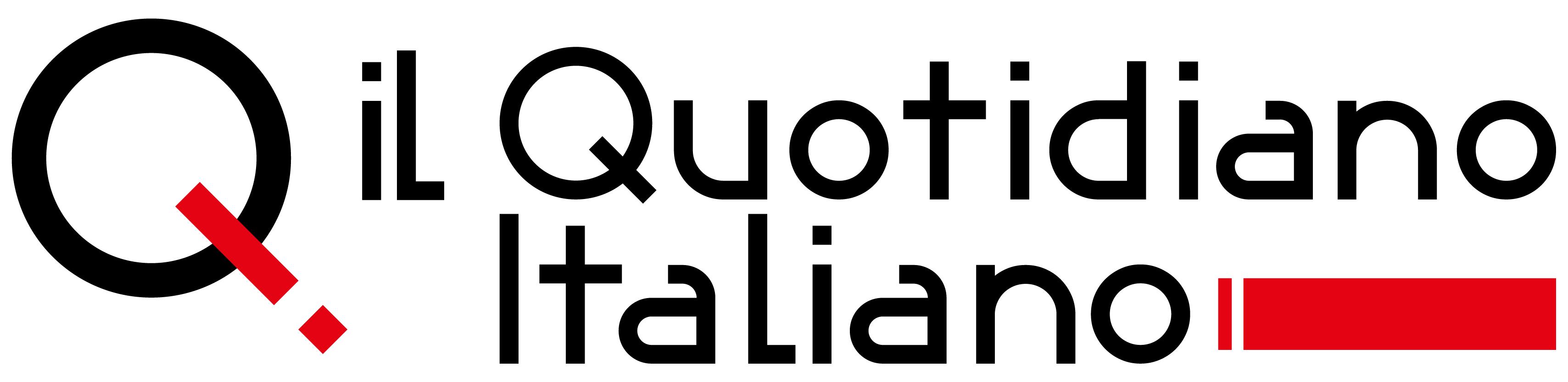Le parole sono importanti, direbbe Michele Apicella, e raccontare una violenza è un’enorme responsabilità. Quando si narra una molestia, uno stupro o un femminicidio bisognerebbe utilizzare la penna o la tastiera come se si stesse maneggiando un preziosissimo reperto, con la massima cautela. Perché il giornalista o lo scrittore (ma anche la giornalista e la scrittrice) si fanno garanti della dignità della survivor e di chi è morta, e lo fanno con il solo mezzo di cui dispongono, le parole.
Il giornalismo tradizionale, pregno di luoghi comuni e ancora habitat di proliferazione di una cultura maschilista, ci hanno abituato a due soli tipi di narrazione: quella in cui la vittima è una povera sventurata, e quella diametralmente opposta, in cui chi subisce la violenza evidentemente se l’è cercata.
La donna angelo e la bestia
Spesso, la Poverina è la vittima di femminicidio. Nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta sempre di una povera ragazza bella e ingenua, di una povera moglie (o ex) esasperata, di una povera madre che lascia i suoi figli. Donne angelicate tanto gentili e tanto oneste quando altrui salutano che non riescono a sfuggire alle grinfie della bestia, l’uomo accecato dal troppo amore o da quello che disgustosamente viene ancora definito amore malato, un terribile e quanto mai inadatto modo per definire una delle tante facce del patriarcato. L’uomo bestia o il grande gigante gentile, come quello del romanzo di Roald Dahl, che in preda ad un fantomatico raptus si prende il lusso di esercitare un potere affidatogli da una cultura tossica e millenaria togliendo la vita a una donna che non possono avere.
Il 25 agosto del 2019 Elisa Pomarelli, 28 anni, venne strangolata dal 45enne Massimo Sebastiani; lei l’aveva rifiutato e lui, per tutta risposta, la uccise e gettò il cadavere in un fossato nelle campagne di Gropparello, nel Piacentino. “Il gigante buono e quell’amore non corrisposto”, il titolo scelto da una famosa testata per raccontare quel terribile femminicidio. Il 5 settembre 2021 Chiara Ugolini, 25 anni, è stata uccisa dal suo vicino di casa Emanuele Impellizzeri, 38 anni. “Bella e impossibile. Alta, bionda, una ragazza che camminava serena incontro alla vita […]”, sono le parole che compaiono all’inizio di un articolo di un’altrettanto nota testata. Un pugno in faccia che non smette di colpire per tutto il pezzo in cui Ugolini, oltre ad essere descritta come inavvicinabile, viene esaltata per il suo essere schiva, per il non dare confidenza a nessuno e per la sua sobrietà. Il carnefice non poteva essere altro che un orco. Nessun accenno al vero movente, al patriarcato, alla cultura dello stupro; solo una principessa, una donna angelicata il cui onore viene usurpato dal lupo cattivo.
La bella di notte che se l’è cercata
Quando non muore, il più delle volte la survivor è complice del boia; talvolta è lei stessa che muove i fili della marionetta che l’ha aggredita. “Ubriache fradicie al party in spiaggia, due 15enni violentate dall’amichetto”. Siamo evidentemente degli estimatori del victim blamig, quella macabra tendenza ad accusare le vittime della violenza subita.
Nell’ottobre del 2020 l’imprenditore Alberto Genovese ha sequestrato e stuprato per 20 ore una 18enne rendendola invalida al 40%. Quella violenza, registrata da 19 telecamere, è stata raccontata da tutti, sulla carta e sugli schermi, talvolta senza risparmiare alcun dettaglio. Giornalisti e opinionisti non hanno accennato ad esimersi dal colpevolizzare la survivor: “Se alla festa a Terrazza sentimento hai notato alcol e droghe, perché non sei andata via?”, “Se entri nella gabbia dei leoni non puoi lamentarti”. Dunque, te la sei cercata, hai fatto in modo che accadesse l’inevitabile e, soprattutto, sei complice di un aggressore che non è più un boia – come nel caso del femminicidio – ma un poveruomo sovraeccitato. Sebastiani era un grande gigante gentile, Impellizzeri un orco che ha ucciso la principessa; ma Genovese resta pur sempre il self-made man, un “imprenditore mago delle startup”, “un vulcano di idee”, quello a cui “piacevano le donne” e che, secondo un suo estimatore, non faticava “a procurarsene in quantità”, dunque “che necessità aveva di rincorrere allo stupro per impossessarsi di una ragazza bella e giovane dopo averla intontita con sostanze eccitanti?”.
Le parole sono importanti
Quando raccontiamo una violenza abbiamo una responsabilità. Nelle nostre parole c’è la dignità di una persona, per questo diventa necessario partire da zero per poter narrare uno stupro o un femminicidio.
Femminicidio. Chiamatelo con il suo nome. Quando il movente è il patriarcato, si chiama femminicidio. Quando un padre uccide la figlia perché lei rifiuta un matrimonio impostole, si chiama femminicidio. Quando un marito viene lasciato e toglie la vita all’ex moglie perché non è più una sua proprietà, si chiama femminicidio. Quando un uomo ammazza la donna che lo ha rifiutato, si chiama femminicidio.
Nomi e cognomi. Roberta, Ylenia, Saman, Chiara, Elena. Chi sono? Sono donne cancellate, e se decidiamo di chiamarle solo per nome, siamo complici di chi le ha eliminate. Roberta Siragusa, Ylenia Lombardo, Saman Abbas, Chiara Ugolini, Elena Casanova. Queste donne avevano un nome e un cognome.
“Amore malato”, “raptus”, “passione”, “gelosia”, “impeto di rabbia”. No, si chiama patriarcato. Alla base di ogni caso di molestia, stupro e femminicidio c’è sempre e solo quella cultura patriarcale in cui, come la rana nel pentolone di Chomsky, continuiamo a sguazzare tutti e tutte (spoiler, la rana muore bollita). Il movente è sempre lo stesso.
“Era depresso”, “era stato tradito”, “si stavano separando”. Non ci sono attenuanti, non ci sono giustificazioni per chi commette un femminicidio, non esiste un casus belli.