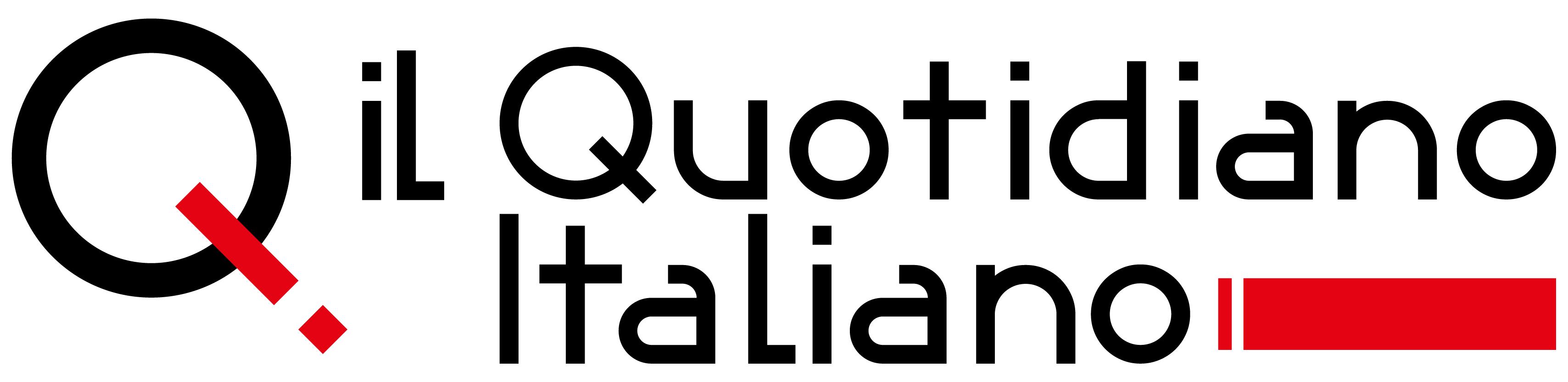Il razzismo nello sport non è più un fenomeno straordinario: coinvolge diverse discipline, giocatori, tifosi, stadi, dirigenti, competizioni prestigiose e gare meno note. Per quale motivo non sempre viene utilizzato come strumento di educazione, coesione sociale ed integrazione? Pensiamo alle origini: per gli antichi greci lo sport era manifestazione di uguaglianza e libertà, i principi cardine della loro civiltà; per i giovani d’oggi è imparare a vivere in un contesto più ampio di regole, cooperazione e confronto con gli altri.
Il paradosso dello “Ius soli sportivo”
Pensiamo anche alla contraddizione dello “Ius soli sportivo“, il decreto approvato dal Senato italiano nel 2016 secondo cui lo sport viene considerato sì come strumento potente di inclusione e veicolo positivo di integrazione, ma nello stesso tempo esclude di fatto una fetta di minori che per un limite di età imposto dalla legge non può partecipare alle attività sportive. Lo Ius soli sportivo infatti prevede la possibilità per i minori stranieri regolarmente residenti in Italia “almeno dal compimento del decimo anno di età” di essere tesserati presso le federazioni sportive “con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani”.
Qual è però il limite della norma? Gli stranieri minorenni, residenti in Italia ma non cittadini italiani, non possono essere convocati per le selezioni in Nazionale. Solo al compimento dei 18 anni, in base alle leggi sulla cittadinanza in vigore in Italia, è possibile avviare la pratica per ottenere la cittadinanza italiana. Questo significa che nel tempo che intercorre tra il tesseramento e la maggiore età, gli atleti non potranno prendere parte alle competizione nazionali, per le quali è richiesta la cittadinanza italiana. Secondo l’ASGI – Associazione studi giuridici sull’immigrazione – “il minore non può mai essere considerato giuridicamente irregolare, indipendentemente dalla posizione giuridica dei genitori”. Il concetto di regolarmente residenti deve essere interpretato “guardando alla dimora abituale e quindi alla semplice presenza del minore sul territorio, indipendentemente dalla condizione di regolarità o meno del soggiorno dei genitori”. Che tradotto significa che lo sport non rappresenta concretamente uno strumento di integrazione per le nuove generazioni.
Sportivo, tifoso o razzista
Il rifiuto dell’altro, che si esprime anche attraverso l’uso della violenza, pure verbale, ha solide radici nella percezione di essere tutt’uno con la propria squadra, nell’esaltazione del proprio clan, nell’identificazione della propria identità con un collettivo. Un collettivo che lo Ius Soli Sportivo non contribuisce a creare, soprattutto se il nostro compagno o l’avversario ha un elemento evidente che lo differenzia da quello standardizzato, come il colore della pelle.
Il calcio, lo sport nazionale per eccellenza attorno al quale ruotano interessi da capogiro, ha da sempre rappresentato l’emblema della tifoseria fanatica per eccellenza ed ha avuto esplosioni di odio costanti. È nel calcio, come testimoniano i numerosissimi episodi di cronaca, che il tifoso fanatico si differenzia dallo sportivo: i comportamenti del primo sfociano nella convinzione di supremazia assoluta nei confronti dell’avversario; il secondo accetta la sconfitta e sostiene comunque la propria squadra.
A proposito di razzismo e intolleranza, ricordiamo con imbarazzo le celebri affermazioni di Carlo Tavecchio, ex Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio: “Noi diciamo che Optì Pobà è venuto qua, prima mangiava le banane, e adesso gioca titolare nella Lazio, e va bene così”; “Io non ho nulla contro i gay, però teneteli lontani da me, io sono normalissimo”; “Finora si riteneva che la donna fosse un soggetto handicappato rispetto al maschio e invece abbiamo riscontrato che sono molto simili”. Episodi più recenti hanno visto l’allenatore del Gallarate, durante una gara del campionato Allievi provinciali, dare del “negretto” ad un sedicenne espulso. E ancora, la velocista azzurra Zaynab Dosso è stata insultata pubblicamente senza ricevere solidarietà da parte di chi ha assistito allo spiacevole episodio.
Eppure lo sport dovrebbe essere terreno fertile per coltivare rispetto, solidarietà ed integrazione e per garantire le stesse opportunità di espressione durante le competizioni, a prescindere dal colore della pelle, dall’età, dal sesso, dall’orientamento sessuale. Perché non insegnare alle future generazioni che la diversità è fonte di ricchezza, accrescimento personale e sociale, opportunità di confronto per allargare la propria visione del mondo, strumento eccezionale per allenare flessibilità e ampliare le proprie conoscenze?
Molto onore, molti nemici
Da quando anche la pallavolo italiana, così come l’atletica, ha riscontrato un aumento della tifoseria, da una nicchia di appassionati ad un vero e proprio seguito, si sono formati nuovi gruppi “tifosi intransigenti” con conseguenti episodi spiacevoli di odio e razzismo. Lo abbiamo visto recentemente con il caso di Paola Egonu, la pallavolista della Nazionale Italiana che durante un video rubato e diventato virale si era sfogata con il suo allenatore: “Mi hanno chiesto perché sono italiana”. Non è di certo la prima volta che in Italia assistiamo a un episodio di discriminazione per il colore della pelle. Ricordiamo ciò che è accaduto a Mario Balotelli nel 2013 quando, durante la partita Milan-Roma, i tifosi romani lo insultarono con il verso della scimmia; o ancora quando, nello stesso anno, il giocatore del Rimini Ameth Fall decise di chiedere all’arbitro un intervento per fermare le incessanti provocazioni dei tifosi monzesi a causa dei continui versi di natura scimmiesca a lui rivolti.
Lo sport per imparare a fare squadra
Lo sport ha nel suo DNA il senso di inclusione: l’ex pallavolista Andrea Lucchetta e commentatore RAI ribadisce ad ogni telecronaca l’importanza di fare squadra nello sport come nella vita, sottolineando come sia potente lo spirito inclusivo tra il pubblico, le famiglie, i più piccoli, e di come uno sport come la pallavolo sia portatore di un messaggio di autentica condivisione. Anche perché è sempre maggiore il numero di atleti di colore che ci rappresentano. E non possiamo far finta che questi ragazzi, solo perché all’apparenza non hanno caratteristiche proprie della fisionomia del cittadino italiano, non siano degni di rappresentare le squadre del nostro Paese. Eppure, l’episodio di razzismo che ha visto protagonista la Egonu si è verificato proprio quando le partite di volley hanno conquistato la prima serata sulle reti RAI raggiungendo un pubblico più vasto, compresa quella parte di italiani intollerante e antisportiva.
Così, ciclicamente, quando è alta la posta in palio, ci ritroviamo a dover affrontare argomenti quali discriminazione razziale, odio, xenofobia legati allo sport. E a domandarci se siamo davvero un Paese di nazionalisti esasperati oppure è un problema che affonda le radici nell’ignoranza culturale e negli stereotipi ancora saldamente radicati nella struttura sociale del nostro Paese. La risposta è in quest’unica certezza: nessuno nasce razzista. Ed è proprio per questo che è di fondamentale importanza porre l’accento sull’educazione, attraverso la scuola e lo sport, per promuovere la condivisione, la solidarietà, l’integrazione, e diffondere il principio universale che la diversità non è un limite, ma una risorsa. Per poter comprendere fino in fondo la celebre frase di Nelson Mandela: “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di suscitare emozioni. Ha il potere di unire le persone come poche cose al mondo. Parla ai giovani un linguaggio che capiscono. Lo sport può creare speranza, dove prima c’era solo disperazione. È più potente di qualunque governo nel rompere le barriere”.